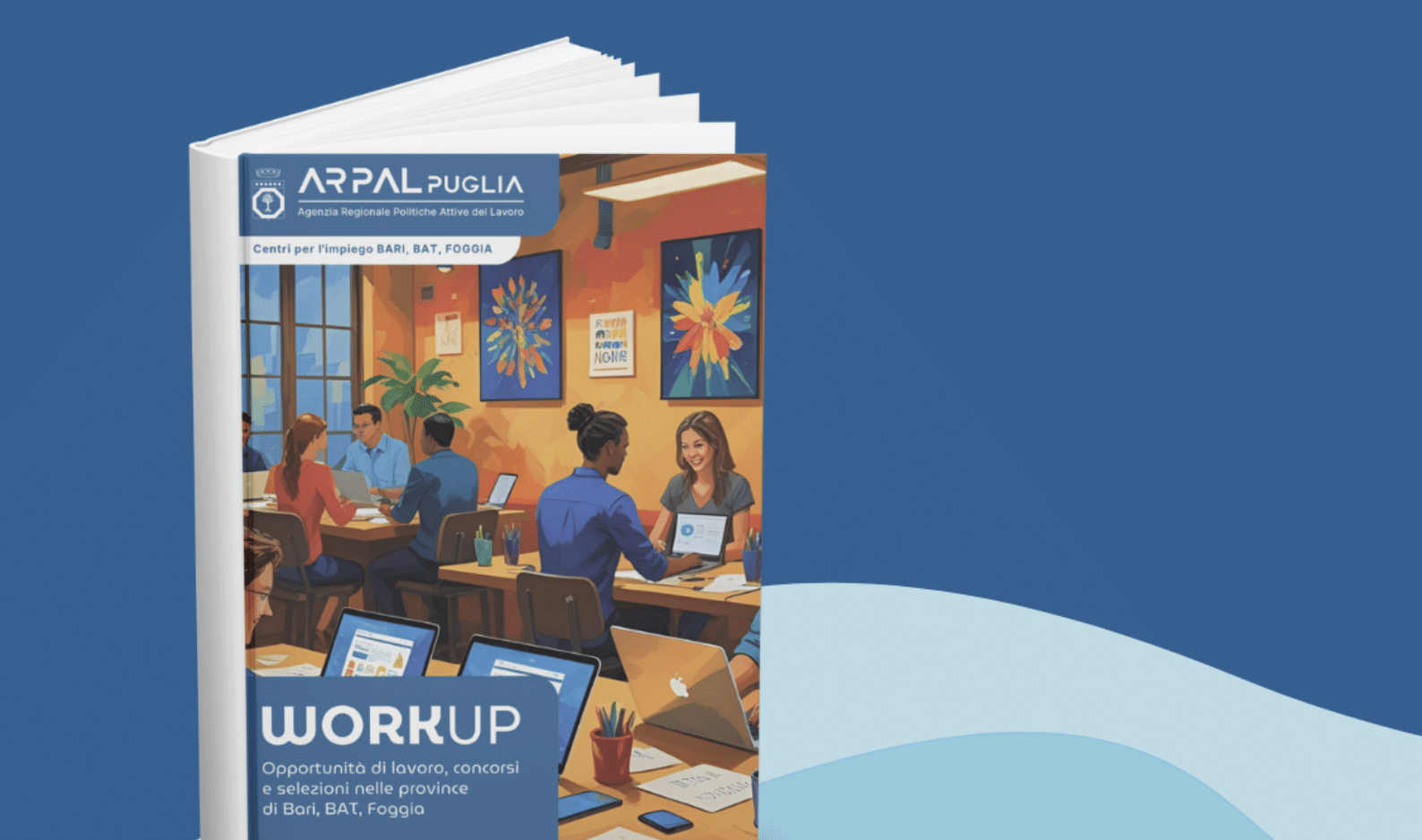“Non è un lavoro per madri”: perché in Italia quando nasce un figlio spesso muore il contratto di una donna?

Le eccellenze femminili, in Italia, non mancano. Dalla scuola alle Università, dalle piccole aziende alle multinazionali, nei settori e nelle specializzazioni più varie le donne hanno dimostrato e dimostrano continuamente le proprie capacità, sia nel lavoro di squadra che in veste di leader. Eppure, tutt’oggi, l’arrivo di un figlio rappresenta un freno a mano tirato bruscamente nella corsa al successo professionale di una professionista. Non sono poche, infatti le porte che chiudono, tra salari più bassi, carriere fragili e, infine, dimissioni. È la fotografia impietosa che emerge da Non è un lavoro per madri firmato da Roberto Rizza, Lorenzo Cattani, Giovanni Amerigo Giuliani e Rebecca Paraciani: un’indagine che non si accontenta dei numeri, ma li attraversa, restituendo le voci e le scelte forzate delle madri italiane.

Il volume intreccia dati nazionali e l’esperienza del Piano per l’Uguaglianza di Bologna, dove oltre seicento genitori – per lo più donne – hanno lasciato l’impiego dopo la nascita di un figlio. Non sono “casi”, sono un sistema. L’infanzia è trasformata in problema privato: servizi che non bastano, orari impossibili, nidi assenti o inaccessibili; congedi parentali pensati peggio di quanto la retorica sulla “famiglia” lasci intendere; soffitti di cristallo che si abbassano a ogni scatto di carriera; lavori segregati “per donne”; divari territoriali e sociali che allargano la frattura tra Nord e Sud, tra chi può permettersi una rete e chi resta sola. È così che la maternità diventa un optional, non una scelta; o peggio una curva che dirotta dal mercato del lavoro proprio chi ha investito di più in studio e qualifiche.
Gli autori del volume puntano il dito contro una cultura che scarica sulle madri la responsabilità dell’organizzazione della vita, celebrandole a parole e sanzionandole nei fatti. E ricordano che l’indipendenza economica non è un dettaglio: è la condizione dell’autonomia, un argine contro la violenza di genere, la possibilità concreta di dire “nella mia vita scelgo solo e soltanto io”. Quando una donna è costretta a lasciare il lavoro, non perde solo reddito: perde libertà, reti, futuro.
La denuncia però non si chiude in un lamento. Il libro indica una via: solo l’incrocio tra politiche innovative – servizi educativi diffusi e accessibili, congedi realmente condivisi, incentivi all’occupazione femminile, contrasto alla segregazione – e una cultura dell’uguaglianza capace di entrare in azienda, nelle scuole, nelle case, può trasformare la maternità da ostacolo percepito a valore condiviso. Ne abbiamo parlato con gli autori stessi.
Come è nata l’idea di questo libro e quali sono stati i criteri per portare avanti l’analisi?
“L’idea del libro nasce da un dato oggettivo, pubblicato ogni anno dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro: in Italia, le dimissioni volontarie dei genitori riguardano in larga maggioranza le madri. Abbiamo voluto mettere in relazione questo fenomeno con altri aspetti cruciali. Innanzitutto, le caratteristiche della partecipazione femminile al lavoro retribuito, che nel nostro Paese rimane significativamente inferiore rispetto alla media europea, segnata da una forte segregazione occupazionale e da carriere più frammentate rispetto a quelle maschili. Un secondo elemento riguarda le politiche di conciliazione vita-lavoro, che in Italia presentano ancora gravi lacune: la carenza di servizi per la prima infanzia (0-2 anni) e il sostegno insufficiente ai genitori rendono complesso l’equilibrio tra lavoro e responsabilità familiari. A ciò si aggiunge una legislazione sui congedi parentali ancora arretrata, che prevede uno scarso coinvolgimento dei padri e risulta quindi poco efficace nel riequilibrare la distribuzione dei carichi di cura tra i generi".
Tra le problematiche affrontate, quale vi è sembrata la più urgente o drammatica? E quale storia in particolare ve l’ha fatta percepire tale?
“È emerso con chiarezza che a decidere di lasciare il lavoro per motivi di cura sono soprattutto donne prive di un supporto familiare offerto dalla rete parentale. Ciò evidenzia come, nel nostro Paese, la famiglia continui a supplire alle carenze delle politiche pubbliche e a un mercato del lavoro ancora fortemente discriminante nei confronti delle donne. Un’altra questione strettamente connessa è la mancanza di politiche di conciliazione realmente efficaci, capaci di tutelare l’occupazione femminile e di impedire che la maternità diventi un ostacolo al percorso professionale. A completare questo quadro interviene una componente culturale tutt’altro che marginale. I nostri dati mostrano che, pur essendo cresciuta negli ultimi decenni la sensibilità verso l’uguaglianza di genere, in Italia persiste una profonda ambivalenza culturale: una parte ancora consistente della popolazione continua a ritenere che il lavoro retribuito possa compromettere il ruolo materno, mentre fatica ad accettare pienamente che i padri possano occuparsi dei figli alla pari delle madri. In altre parole, il sistema di valori resta ancorato a modelli tradizionali che ostacolano la condivisione della cura e alimentano l’idea che maternità e lavoro siano in conflitto, invece che dimensioni compatibili e complementari.”
Luce